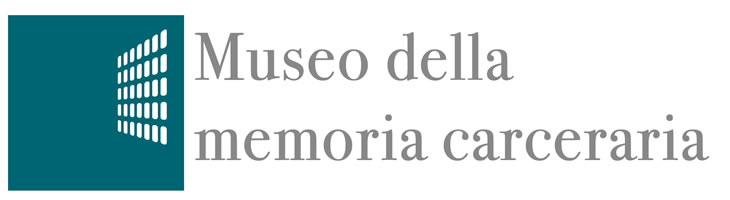«Fine pen(n)a mai», 40 storie dal carcere
«Fine pen(n)a mai» è il libro di racconti scritti da quaranta ragazzi del liceo siracusano Einaudi. I giovani hanno incontrato i detenuti, li hanno conosciuti e hanno provato a trascrivere le loro vite

«Nel mio caso vi è da dire che, quando ho iniziato a frequentare determinate persone, ero molto giovane e dunque molto inesperto.
Vorrei aggiungere che se mi venisse chiesto di tornare indietro, di sicuro non rifarei gli stessi errori che oggi mi costano la libertà. Ma è ovvio che, solo adesso conoscendo il mio passato, posso affermare ciò. A volte mi è capitato di essere richiamato dai miei familiari perché avevo queste frequentazioni poco raccomandabili… non gli davo retta, perché non ero consapevole del fatto che tali conoscenze mi avrebbero causato solo e soltanto guai.
E non parlo soltanto dei guai giudiziari, ma anche di quelli che colpiscono gli affetti più cari: il dover vedere i propri figli senza poter condividere con loro quelli che sono i momenti più significativi della loro crescita, il non poter dare ai propri genitori una carezza mentre invecchiano; tutto questo diventa insopportabile nonostante la rassegnazione».
Stefano ha 47 anni e da circa venti vive nel carcere di Brucoli, in provincia di Siracusa. Lui e altri 39 detenuti hanno incontrato quaranta giovani studenti del liceo Luigi Einaudi di Siracusa, in piccoli gruppi da due o tre persone. Si sono visti per tre volte, in carcere. Si sono presentati, parlati, guardati dentro. I detenuti hanno raccontato a quei ragazzi la loro storia e gli studenti hanno cercato di scrivere, per ognuna delle loro vite, un racconto. Un progetto di alternanza scuola – lavoro, e il risultato è un libro, Fine pen(n)a mai, per la collana Selfie di Noi della casa editrice romana Gemma. Storie raccontate a più voci e scritte a più mani.
La storia di Stefano si chiama Quale porta vuoi aprire: l’hanno scritto Simona L. e Greta B. «Ci ha raccontato la sua vita quando lo abbiamo incontrato, poi ci ha spedito qualche lettera. Sta scontando 27 anni di carcere per quelli che lui definisce “giri illeciti”, non sappiamo se di droga o di armi, e per omicidio».
Nessuno dei ragazzi era mai entrato in carcere prima. «Chiedere le autorizzazioni, ricevere un pass, vedersi aprire un cancello enorme e le serrature delle celle è stata un’esperienza molto forte», spiega Simona. «Prima di farla, non sapevamo se i detenuti portassero le manette e indossassero una divisa arancione. Niente di tutto questo: ci siamo parlati tranquillamente, ci siamo stretti la mano, e di volta in volta abbiamo preso sempre più confidenza. All’inizio eravamo imbarazzati: non volevamo risultare troppo invadenti o farci vedere prevenuti. Poi però si è instaurato un rapporto di rispetto: abbiamo imparato qualcosa gli uni dagli altri».
Ad esempio, che la scuola è molto più importante di quanto la possa percepire un liceale. «I detenuti hanno capito che lo è, soprattutto da quando sono in carcere. Quasi tutti cercano di studiare, di prendere il diploma o, se ancora non l’avevano, la terza media. Stefano, come noi, farà l’esame di maturità il prossimo anno, proprio come noi: era già emozionato, in ansia come un diciottenne».
Parlano di amicizie sbagliate, di quartieri poveri e desolati, dove delinquere era la norma. «Ma nessuno incolpa le famiglie, anche se qualcuno sarà cresciuto in contesti disfunzionali, sicuramente. La lontananza dagli affetti è il rimpianto più grande: Stefano dice che gli pesa non essere con la figlia, ancora di più che dover rimanere in una cella. Altri si sono posti l’obiettivo di uscire in tempo per veder crescere i nipoti, per fare i nonni: è il loro pensiero di speranza per sopravvivere».
E quasi tutti i detenuti, spiegano i ragazzi, guidati dalla professoressa Maria Grazia Guagenti, dicono di essere innocenti. «Stefano ce lo ha assicurato, ma ha detto di non potersi difendere. Il perché ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca: diceva di non voler “fare la spia”. “Non posso dimostrare la mia innocenza, altrimenti farei la spia, e noi non possiamo”. Dopo vent’anni di carcere, ancora non è riuscito a dimenticare questa parola. È triste».
Hanno sbagliato, ancora sbagliano, ma hanno tante cose da dire e da insegnare, e spesso non riescono a farlo. «Il progetto consiste nel dare voce a chi non ce l’ha: noi ci abbiamo provato, a rompere quella barriera di silenzio che separa due mondi. Non abbiamo trovato mostri: da una parte e dall’altra, nient’altro che uomini».
LEGGI ANCHE
Il racconto di Floriana, detenuta a Rebibbia: «Avrei voluto un’altra vita»
LEGGI ANCHE
Quando il lavoro rende liberi. Dal carcere alla vita
LEGGI ANCHE
Bambini, il diritto a giocare con papà in carcere
Fonte: MONICA COVIELLO, Vanity Fair