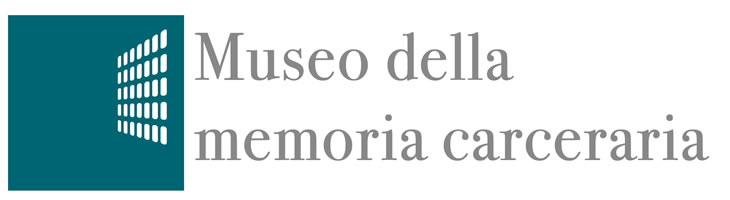Il Progetto
Il Museo della memoria carceraria della Castiglia di Saluzzo. A cura di Claudio Sarzotti.

Premessa
Perché un museo sulla storia del carcere? Ed è possibile parlare di museo, o non piuttosto di luoghi nei quali, nella nostra società della emotività massificata, “è ancora possibile provare un sentimento di meraviglia che solo l’opera d’arte è in grado di comunicarci nel momento in cui ci mostra la possibilità del possibile” (G. Di Giacomo, 2012, p. 7)? Com’è pensabile suscitare questa meraviglia quando il contenuto del museo è rappresentato non da opere d’arte, ma da oggetti “poveri”, documenti d’archivio e narrazioni che raccontano la storia di un’istituzione che ha sempre avuto tra i suoi compiti principali quello di “amministrare la sofferenza” (P. Buffa, 2013)?
Queste sono solo alcune delle questioni che mi posi quando, nel 2010, il Comune di Saluzzo mi assegnò l’incarico di curatore scientifico dell’allestimento del Museo della memoria carceraria alla Castiglia[1]. Antica dimora del Marchesato di Saluzzo, costruita tra il 1270 e il 1286 dal Marchese Tommaso I alla sommità del borgo medioevale di una città che per quattro secoli sottrasse ai Savoia il dominio del basso Piemonte, la Castiglia, come istituzione penitenziaria, ha attraversato gran parte della storia del Regno di Sardegna e dello Stato nazionale. Dalla sua ristrutturazione ad istituto di reclusione del 1828, essa ha accompagnato la fase risorgimentale, i primi decenni dell’Unità nazionale, il ventennio fascista, le vicende della Repubblica sino alla chiusura avvenuta nel 1992, in seguito alla costruzione dell’attuale carcere intitolato a Rodolfo Morandi[2] a pochi chilometri dalla cittadina cuneese. A ciascuno di questi periodi storici hanno corrisposto specifiche concezioni della pena e scelte di politica criminale, ma di certo la Casa di reclusione e di lavoro di Saluzzo è stata il primo esempio di carcere moderno del sistema penitenziario sabaudo, sistema che, come noto, ha rappresentato il modello da cui ha preso le mosse quello del nuovo Stato nazionale.
Inoltre, si trattava di raccontare la storia di un singolo carcere non tralasciando, al tempo stesso, la storia dell’istituzione penitenziaria in generale, avendo come obiettivo quello di parlare ad un pubblico quanto più possibile ampio, spesso carente di cultura storica e la cui idea di carcere è sovente disseminata di stereotipi veicolati dai mass media. Tutto ciò avendo a disposizione solamente non moltissimi reperti storici miracolosamente salvati dall’incuria di una amministrazione poco attenta alla conservazione della sua memoria e dall’assalto dei collezionisti di memorabilia carcerarie che hanno operato un ampio saccheggio nei primi anni della dismissione della Castiglia, quando, non essendo ancora transitata nella sfera di competenza del Comune di Saluzzo, è rimasta per qualche tempo pressoché incustodita.
La tradizione dei musei criminologici e della tortura
Il progetto di un allestimento di un museo sul tema carcere deve tener conto di due filoni museali che, pur non avendo come oggetto esclusivo la prigione, hanno affrontato temi affini a quello della detenzione. Il primo di questi filoni ha una tradizione scientifica ben consolidata e, soprattutto in Italia, alcuni esempi di notevole levatura: si tratta dei c.d. musei criminologici che hanno ricostruito in particolare la storia dell’antropologia criminale ottocentesca, ovvero quel sapere che si è strutturato proprio a partire dal consolidarsi dell’istituzione carceraria moderna. Principale esempio in Italia, ma probabilmente nel mondo, di tale filone è il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino, ma non si può non citare anche il Museo criminologico (già Museo criminale dell’amministrazione penitenziaria) di Roma, depositario istituzionale della memoria storica dell’amministrazione penitenziaria italiana[3]. Entrambi questi musei, tra l’altro, hanno collaborato all’allestimento museale saluzzese fornendo materiale iconografico di elevato interesse storico[4].
Il secondo settore museale che ha toccato temi in senso lato carcerari ha invece una storia molto più recente e fondamenti scientifici spesso assai labili (in alcuni casi pressoché inesistenti): alludo al proliferare dei musei della tortura che sono nati in Europa e in molti luoghi del nostro Paese. Si tratta in alcuni casi di musei che hanno una certa tradizione e accuratezza storiografica come il Museo criminale e della tortura della cittadina tedesca di Rothenburg sul Tauber; in altri casi, di iniziative che hanno come scopo principale quella di attirare l’attenzione dei turisti attraverso l’esposizione di strumenti che fanno immaginare (e talvolta lasciando poco spazio all’immaginazione …) corpi sezionati, membra stritolate e altre amenità di darioargentesca memoria[5]. Musei che trasmettono un generico richiamo al processo di civilizzazione dell’uomo moderno liberatosi dalle barbariche e medioevali pratiche di tortura, titillando tuttavia l’istinto voyeuristico del visitatore attratto dall’esposizione della sofferenza inflitta sul corpo del condannato. In tale prospettiva, viene abbandonata spesso ogni rigorosità filologica e soprattutto il carcere moderno viene assimilato agli antichi luoghi di detenzione che nulla avevano a che spartire con l’esercizio del potere disciplinare, ma erano contesti di mera segregazione per mettere a disposizione delle autorità sovrane i corpi degli inquisiti. Assimilazione che ha come effetto collaterale (indesiderato?) quello di ribadire un’acquisizione molto diffusa nella cultura popolare: che il carcere sia sempre esistito nella storia dell’umanità. In effetti di carcere si parla sin dalla Bibbia[6], ma quello che, a mio parere, vale la pena rammentare al visitatore in un museo del carcere che voglia essere storicamente corretto e culturalmente progressista è il carattere relativamente recente del progetto disciplinare del carcere moderno. Un progetto che inizia, dal punto di vista delle teorie della penalità, nella seconda metà del Settecento con il panottico benthamiano e che già sul finire dell’Ottocento mostra i segni della inattuabilità e di un mutamento di funzione. Per rimanere alla storia della prigione del nostro Paese, e in particolare a quella del Piemonte, è possibile indicare simbolicamente due date che conchiudono questa breve parabola: il 1828, data di inaugurazione della Casa di reclusione e di lavoro di Saluzzo, e il 1888, data di pubblicazione dell’opera di Lombroso, Palimsesti del carcere, nel quale il criminologo veronese conclude la sua analisi dei graffiti con cui i reclusi istoriano le mura delle celle con l’affermazione “che precisamente gli scopi cui di più si mira col carcere cellulare sono quelli che meno si conseguiscono. (…) Una parte dei recidivi è stata istruita nel carcere e deve il mutamento della propria criminalità all’istruzione carceraria, la quale non ha fatto che acuirla nel crimine e darle un nuovo indirizzo più pericoloso. (…) Ora vale la pena che il Governo, che ha tante altre cose da fare, spenda per ottenere questo bello scopo?” In sintesi, una vera e propria dichiarazione di fallimento di quel progetto disciplinare che aveva avuto l’ambizione di forgiare il cittadino delle moderne democrazie occidentali, da parte di colui che più di ogni altro aveva sperimentato e affinato il sapere criminologico.
Ribadire che il carcere è dunque un’istituzione con una storia relativamente recente significa trasmettere due messaggi culturali molto importanti. Per un verso, ricostruire la storia del carcere non significa occuparsi di un’istituzione marginale e di rilievo solo per coloro che si occupano della storia della penalità, ma di ricomporre il processo di costituzione della società moderna tout court e del suo tramonto in quell’epoca indefinita che chiamiamo post-modernità o tardo-modernità. Per altro verso, se per millenni sono esistite società senza carceri sono ipotizzabili società future che possano fare a meno della realtà detentiva. Riflettere su questo assunto, inoltre, inocula nei visitatori un salutare vaccino contro ogni assolutizzazione ontologica di un’istituzione relativamente recente, scaturita da determinate contingenze storiche e quindi superabile con il venir meno delle condizioni che l’hanno prodotta[7].
L’impianto scientifico del progetto museale
Ricostruito il contesto entro il quale il museo ha preso forma, veniamo ora a descrivere brevemente qual è stato il progetto di allestimento. Innanzitutto, il luogo espositivo. È stato acutamente osservato a proposito dei musei che contengono opere d’arte come “il museo preferisce oggi esibire prima di tutto se stesso, […] entra in qualche modo in competizione diretta con l’opera d’arte facendosi opera d’arte esso stesso” (F. Purini, 2003, p. 13), in un corto circuito emotivo in cui contenente e contenitore si richiamano reciprocamente e quest’ultimo diventa esso stesso oggetto di culto e di attrazione (cfr. G. Di Giacomo, 2012, p. 8 ss.). Se questo è vero per i musei d’arte, a maggior ragione un legame di questo tipo si instaura quando si presenta il racconto delle vicende storiche di una istituzione nello spazio stesso in cui essa ha operato. Nel caso della Castiglia, l’edificio è stato scorporato in due parti attuando una completa ristrutturazione dei piani superiori[8] per ospitarvi il Museo della civiltà cavalleresca dove sono stati ricostruiti gli ambienti dell’antico palazzo sede del Marchesato. Il Museo della memoria carceraria, invece, è stato collocato nelle sezioni detentive semi-interrate che sono state utilizzate come celle di disciplina e di isolamento sino quasi alla chiusura dell’istituto nel 1992. Questa parte dell’edificio è stata conservata nello stato in cui si trovava al momento della dismissione del Ministero della Giustizia e fa quindi da sfondo all’allestimento museale, interagendo con esso in più punti del percorso espositivo.
È il caso, ad esempio, dei graffiti carcerari che sono stati recuperati e documentati[9] attraverso il contributo, artistico oltre che scientifico, del fotografo Davide Dutto, noto per i suoi lavori “carcerari”[10]. Il visitatore, in tal modo, può incontrare “dal vivo” senza alcuna mediazione, che non sia quella di un supplemento informativo fornito dall’allestimento museale, tracce di vita reclusa che spaziano per un arco temporale di 250 anni[11]. Altrettanto può dirsi quando il racconto di alcuni dei piccoli e grandi protagonisti delle vicende ottocentesche della Castiglia, attraverso l’uso della realtà virtuale, si materializza in ologrammi parlanti con cui il visitatore vede e ascolta tali personaggi nel contesto reale delle celle in cui sono stati reclusi, o hanno operato, più di un secolo prima.
Il metodo espositivo scelto, infatti, è stato quello narrativo, sebbene non si sia voluto rinunciare ai classici pannelli espositivi e ad otto video in cui vengono illustrati i principali aspetti della storia dell’istituzione carceraria moderna facendo riferimento alla storiografia più accreditata[12] e ad una ricerca iconografica molto complessa per il tema trattato[13]. La narrazione, infatti, è quella che coinvolge maggiormente il visitatore sia quando colui che narra è un perfetto sconosciuto, sia quando si tratta di un personaggio che, per lo meno nella sua epoca, ha goduto di una certa notorietà. Negli ologrammi del museo della Castiglia sono rappresentate entrambe queste categorie: si va da personaggi come Giulia Colbert Falletti Marchesa di Barolo, una delle maggiori protagoniste a livello europeo della storia della detenzione femminile, che con il carcere femminile di Saluzzo ebbe documentati rapporti organizzativi (E. Pianea, 2008, p. 104), a personaggi meno noti, ma che si ritagliarono uno spazio non irrilevante nella storia della carcerazione sabauda, come il saluzzese Giovanni Eandi[14] e il primo direttore del carcere di Saluzzo, Giacomo Caorsi[15]. Per giungere, invece, a coloro che nella storia ufficiale non ebbero alcuna voce come i detenuti che, nel Natale del 1848, inviarono le loro suppliche all’Ispettore delle carceri sabaude per ottenere uno sconto di pena raccontando le loro patetiche vicende che li avevano portati in carcere[16], o alla “cinematografica” vicenda di un certo Domenico Rollino, piccolo brigante diventato collaboratore di giustizia (allora detti propalatori), che per essere sottratto alla vendetta dei suoi compari malviventi venne destinato alla Castiglia come arciere, ovvero le guardie che avevano il compito di dare esecuzione con lo staffile alle pene corporali per i reclusi indisciplinati. La mattina del 24 agosto 1842, tuttavia, Rollino abbandonò il servizio in Castiglia, camminò per una trentina di chilometri e all’imbrunire entrò in una taverna con la pistola di servizio che gli spuntava da una tasca dei pantaloni. Un inserviente diede l’allarme e un paio di carabinieri entrarono nel locale per chiedere i documenti; Rollino, vistosi scoperto, urlò “questa è una pistola che non manca, pria di soffrire un qualche affronto, piuttosto la sparo contro di me; guardate bene se manca” e puntando la pistola alla propria gola fece fuoco davanti agli avventori esterrefatti.
Altra vicenda raccontata nel museo, stavolta con l’ausilio tecnico di un manichino parlante di inquietante verosimiglianza collocato in una scenografia di straordinario impatto visivo frutto del genio artistico e tecnologico del film-maker torinese Nino Lepore, è quella di uno dei più famosi briganti piemontesi dell’Ottocento: Francesco Delpero, le cui “gesta” criminali finirono con la sua impiccagione nella piazza del mercato di Bra nell’estate del 1858. I documenti d’archivio testimoniano di due passaggi del brigante al carcere di Saluzzo[17] e la cella che è stata scelta per il manichino è quella che maggiormente evoca le terribili condizioni dei reclusi ottocenteschi. Anche qui il luogo museale quindi interagisce evocativamente con la vicenda di un soggetto che catturò l’attenzione dell’opinione pubblica piemontese tanto che il suo arresto venne raccontato qualche anno più tardi da Edmondo De Amicis (1892, pp. 177-183), in un periodo storico in cui per la prima volta in Italia i fatti di cronaca nera diventavano oggetto dell’attenzione dei giornali e strumento di lotta politica.
Una sezione del museo è dedicata ad un fenomeno affine al carcere, ma che va tenuto distinto da esso: la relegazione per motivi politici e religiosi. La relegazione in fortezze o castelli posti in luoghi inaccessibili è stata una forma di detenzione che ha avuto analogie con la carcerazione moderna dal punto di vista materiale, ma che se ne è differenziata profondamente per finalità e modalità di gestione della vita detentiva. Nella relegazione non erano presenti i dispositivi disciplinari del carcere riservati alle classi sociali pericolose e permanevano tracce considerevoli della segreta premoderna, una pena di morte differita per quei personaggi borghesi o aristocratici che rappresentavano un’insidia per l’autorità del sovrano. Tale distinzione è emersa chiaramente nella prima metà dell’Ottocento quando carcere disciplinare e relegazione hanno convissuto per molto tempo nella storia del nostro Risorgimento[18]. Negli stessi anni in cui Silvio Pellico scontava la sua relegazione allo Spielberg, il governo sabaudo progettava alla Castiglia il primo carcere disciplinare del Piemonte chiamandolo Nuova Casa di Reclusione e di Lavoro, ospitando tra le sue mura un’alta percentuale di individui “sospetti e oziosi” che non erano stato condannati con sentenze penali, ma “per via economica”, ovvero con provvedimenti stragiudiziali di tutela dell’ordine pubblico[19].
Nel museo vengono rievocati tre episodi storici che hanno avuto il carcere di Saluzzo come protagonista diretto o indiretto della relegazione: la segregazione del popolo valdese nell’inverno del 1686 prima del suo esilio ginevrino e il successivo Glorioso rimpatrio[20]; la relegazione dei patrioti risorgimentali nelle fortezze sabaude e quella del più illustre dei saluzzesi Silvio Pellico e dei suoi compagni di sventura allo Spielberg; la detenzione degli antifascisti durante quel Ventennio in cui la relegazione per motivi politici ebbe una triste recrudescenza.
Venendo alla “storia del presente”[21], all’interno del museo esiste una sezione che mostra come il carcere moderno sia entrato nella cultura popolare ed abbia interessato varie forme di espressione artistica. In tale sezione, denominata Carcere e mondo dell’arte , troviamo una biblioteca multimediale in cui sono collocate, in un ambiente carcerario ricostruito con la realtà virtuale, le principali opere letterarie e cinematografiche (le due forme di espressione artistica, come noto, si richiamano vicendevolmente) che hanno fatto entrare l’istituzione penitenziaria nell’immaginario collettivo; uno schermo touch screen nel quale è possibile viaggiare nel mondo multicolore dei manifesti pubblicitari dei più noti prison movies; le riproduzioni delle incisioni delle Carceri d’invenzione di Giovanni Battista Piranesi e i disegni che il noto pittore Aligi Sassu produsse nel vicino carcere di Fossano dove era detenuto come militante antifascista.
Tra le forme d’arte in cui il carcere ha ottenuto cittadinanza, la musica popolare. Nel museo è possibile ascoltare due celebri canzoni di due mostri sacri della musica italiana scomparsi da non molti anni: la mitica Don Raffae’ di Fabrizio De Andrè e La casa in riva al mare di Lucio Dalla. Tale ascolto è messo in relazione con oggetti ritrovati al momento della smobilitazione del carcere di Saluzzo e risalenti agli anni Sessanta-Settanta: una piccola caffettiera napoletana da due tazzine e una raccolta di cartoline illustrate e lettere d’amore spedite/ricevute dai reclusi di Saluzzo (convenientemente rese anonime). L’autenticità di questi piccoli reperti che si trovano nel museo[22], al di là della loro apparente insignificanza nella prospettiva della storia événementielle, in realtà predispongono al coinvolgimento emotivo del visitatore che è messo in grado di immaginare le condizioni della vita reclusa che li hanno prodotti. In passato oggetti simili a questi, quelle che Lombroso chiamava le malizie carcerarie[23], sono stati considerati “da museo” nella misura in cui rappresentavano segni della personalità criminale del recluso; qui la prospettiva è invertita ed essi raccontano dell’inesauribile vitalità delle persone recluse nel sottrarsi al potere disciplinare dell’istituzione totale. Ed è questo il secondo senso[24] per cui quello saluzzese credo possa essere considerato il primo museo di matrice focaultiana in Italia (nel mondo?). Come noto, il pensiero di Michel Foucault è stato utilizzato anche per scrivere la storia dell’istituzione museale moderna (cfr. in particolare E. Hooper-Greenhill, 2005); in questa prospettiva, il museo è stato considerato un dispositivo con cui, da un lato, si sono celebrati i progressi della scienza di stampo positivistico, dall’altro, si sono selezionate le opere dell’intelletto, del genio artistico etc. degne di essere messe in mostra, di essere additate al pubblico esempio. Esponendo in un museo questi piccoli manufatti di individui marginali, facendo cortocircuitare allestimenti raffinati con oggetti costruiti con materiale povero[25], si riesce per certi versi a riconvertire tale dispositivo, si riesce a sfruttarlo in una direzione diversa da quella progettata da chi inventò il museo moderno, a giocare un’altra partita in favore della resistenza al potere disciplinare. Ho la presunzione di credere che un’operazione di questo genere sarebbe piaciuta a Michel Foucault.
Claudio Sarzotti
[1] Il Museo è stato inaugurato il 22 febbraio 2014 ed è in preparazione un sito internet che ne illustrerà le caratteristiche e fornirà ulteriori materiali di approfondimento sui temi della storia carceraria (per informazioni sulle visite e sulle modalità di fruizione per gruppi di visitatori si può scrivere a: iat@comune.saluzzo.cn.it).
[2] Illustre antifascista, membro della Costituente, ministro e segretario del Partito Socialista nell’Italia repubblicana, fu detenuto a Saluzzo negli anni 1940-1943; la sua figura viene ricordata anche nel museo saluzzese nella sezione sulla relegazione politica, vedi infra.
[3] Sulla storia del museo romano e dei suoi rapporti anche con quello lombrosiano, cfr. A. Borzacchiello, 1997. Una ulteriore sottospecie di tale filone è rappresentato dai musei che fanno la storia della polizia e dei sistemi di rilevazione dattiloscopica, per tutti quello della Préfecture de Police di Parigi. Il museo saluzzese contiene una sezione su questi temi relativi ai rituali di degradazione a cui viene sottoposto il recluso all’entrata in carcere e con il racconto della nascita dei moderni strumenti di identificazione del reo (foto segnaletica e impronte digitali). Il visitatore stesso, se desidera, può sottoporsi a tali rituali, in particolare riproducendo i propri connotati in una foto segnaletica in forma di gadget.
[4] In particolare, vorrei segnalare uno spettacolare disegno su carta telata dell’Atlante lombrosiano del corpo tatuato a grandezza naturale di un detenuto monregalese e le foto in bianco e nero di interni delle carceri italiane dell’archivio del Museo criminologico di Roma che furono parzialmente pubblicate in A. Di Lazzaro, M. Pavarini (1994).
[5] In Italia una regione particolarmente ricca di tali iniziative è la Toscana (vedi, a tal proposito, il sito www.museodellatortura.it). In Europa, uno dei primi musei di questo tipo è quello degli strumenti di tortura di Amsterdam ed entro questa categoria può essere fatto rientrare anche il Clink Prison Museum di Londra.
[6] Si pensi al celebre episodio della Genesi in cui Giuseppe, figlio prediletto di Giacobbe, viene incarcerato ingiustamente in seguito alla calunnia della moglie del suo padrone Potifar e si salva dalla prigione per la sua capacità di interpretare i sogni del Faraone.
[7] È del tutto evidente, del resto, come l’attuale sistema carcerario del XXI secolo già differisca per innumerevoli aspetti dall’originario modello disciplinare ottocentesco.
[8] In questa parte dell’istituto erano situati i cameroni nei quali i reclusi erano alloggiati in ampie stanze detentive da venti-trenta posti. Il carcere di Saluzzo, infatti, non è stato concepito come struttura detentiva cellulare e questo è stato uno dei motivi principali del suo fallimento come strumento disciplinare (cfr. S. Montaldo, 2008a).
[9] Parte di questa documentazione fotografica è stata già esposta nella primavera del 2013 nella mostra itinerante eVisioni. Il carcere in pellicola, collage e graffiti (cfr. C. Sarzotti, G. Siniscalchi, 2013) al Campus Luigi Einaudi di Torino, al Palazzo ex Poste dell’Università di Bari e alla Castiglia di Saluzzo.
[10] È da ricordare, in particolare, per la qualità artistica e sociologica della ricerca e il successo editoriale registrato, il suo libro fotografico Il Gambero nero (D. Dutto, M. Marziani, 2005), nel quale Dutto ha ricostruito coi detenuti quella attività, così importante per sottrarsi agli effetti perversi della prigionizzazione, costituita dal cucinare il proprio cibo in cella.
[11] Sono stati ritrovati graffiti che vanno da una sicura datazione risalente al 1742, ovvero in un periodo precedente allo stesso utilizzo carcerario della Castiglia (testimonianze probabilmente della relegazione premoderna), sino alle più recenti incisioni dei detenuti degli anni Ottanta. Di particolare valore, una incisione, datata 1865, su di una porta in legno di una cella eseguita ad opera di un detenuto.
[12] Occorre peraltro precisare che la scelta di prospettiva teorica consapevolmente privilegiata è stata quella foucaultiana, in particolare attraverso l’enfatizzazione del nesso esistente tra invenzione del carcere moderno e avvento della società disciplinare, vedi infra.
[13] Come noto, in Italia il tema carcerario non è mai stato considerato degno di attenzione dagli incisori e dai fotografi ottocenteschi per cui gran parte dell’iconografia penitenziaria di quell’epoca, a cui si è attinto per il museo saluzzese, è di matrice francese e anglosassone.
[14] Il “piccolo Tocqueville sabaudo”, in quanto intraprese nella primavera-estate del 1840 un lungo viaggio in Europa per visitare i principali istituti penitenziari e per riferire al Governo quali fossero “quelli rimarchevoli e degni di imitazione”, in preparazione della nuova politica criminale sabauda inaugurata con il codice penale carloalbertino del 1839 e la costruzione dei primi edifici carcerari ad hoc di Alessandria (Eandi ne fu il primo direttore) e Oneglia. Sulla figura di Eandi, cfr. S. Montaldo, 2008b.
[15] Il “Brubaker che veniva da Genova”, già direttore del carcere genovese di S. Andrea, direttore illuminato e liberale che venne nel giro di qualche anno esautorato dalla amministrazione perché nemico giurato delle pene corporali e troppo propenso ad interpretare il regolamento in favore dei reclusi. Della sua esperienza saluzzese fece un resoconto dettagliato che inviò al Parlamento subalpino nel 1850 (cfr. G. Caorsi, 1850). Sull’intera vicenda di Caorsi a Saluzzo, cfr. anche S. Montaldo, 2008a, pp. 41-52.
[16] Ho avuto modo di analizzare queste lettere in un lavoro prodromico al lavoro di allestimento del museo saluzzese (cfr. C. Sarzotti, 2008).
[17] Sulla figura di Delpero è fondamentale il lavoro dello storico del brigantaggio piemontese Milo Julini (1999) che ha collaborato come consulente scientifico all’allestimento museale saluzzese.
[18] La distinzione era talvolta regolata anche giuridicamente come nel codice penale del 1839 emanato da Carlo Alberto, nel quale all’art. 13 si distingueva la pena della reclusione da quella della relegazione “in luoghi forti”.
[19] In ciò la detenzione alla Castiglia nei primi anni della sua costituzione manteneva le tracce di quel fenomeno di internamento della povertà e del vagabondaggio che, come noto, rappresentò in tutta Europa l’anticamera della carcerazione moderna. Cfr. per tutti, D. Melossi, M. Pavarini (1977, p. 31 ss.).
[20] Vicenda, quella della persecuzione del popolo valdese, che assunse la misura di un vero e proprio sterminio e deportazione di massa, inquietante residuo delle lotte di religione cinque-secentesche e profetica allusione ai totalitarismi concentrazionari del XX secolo. La ricostruzione dell’intera vicenda la si può trovare nel monumentale lavoro d’archivio dello storico valdese Arturo Pascal pubblicato a puntate sul Bollettino di Studi Valdesi in un arco di tempo che va dal 1937 al 1968.
[21] Nota espressione foucaultiana che descrive molto bene la prospettiva teorica del museo di Saluzzo che avrebbe la presunzione di raccontare qualcosa di non banale sul presente facendo la storia del passato.
[22] Ve ne sono altri tutti risalenti ad un periodo che va dal primo dopoguerra agli anni Ottanta, quali ad esempio manubri e bilancieri per fare ginnastica costruiti con materiali di fortuna, scarpe prodotte dal laboratorio del carcere con relativi strumenti di lavoro, inquietanti camicie di forza utilizzate con ogni probabilità per legare i detenuti ad un letto di contenzione (anch’esso ritrovato), divise da detenuto che erano ancora utilizzate poco prima della riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, “malizie carcerarie” come coltellini e false chiavi costruite dai reclusi etc.
[23] Attraverso la consulenza di un ex detenuto è stato possibile ricostruirne qualcuna, tra le quali si segnala un fantascientifico alambicco per distillare la grappa, costruito con cateteri rubati in infermeria da utilizzare come serpentina per far condensare il vapore dell’alcol prodotto dalla fermentazione della frutta sottratta alla mensa dell’istituto.
[24] Il primo, come detto, è relativo all’impostazione teorica adottata per l’intero progetto dell’allestimento museale.
[25] Di straordinaria qualità artistica e di impressionante precisione calligrafica la serie di interni del carcere di Bolzano costruiti con materiale di risulta da Luciano Adami che vengono esposti al museo in modo da essere visibili solamente attraverso gli spioncini di sorveglianza delle celle di isolamento.